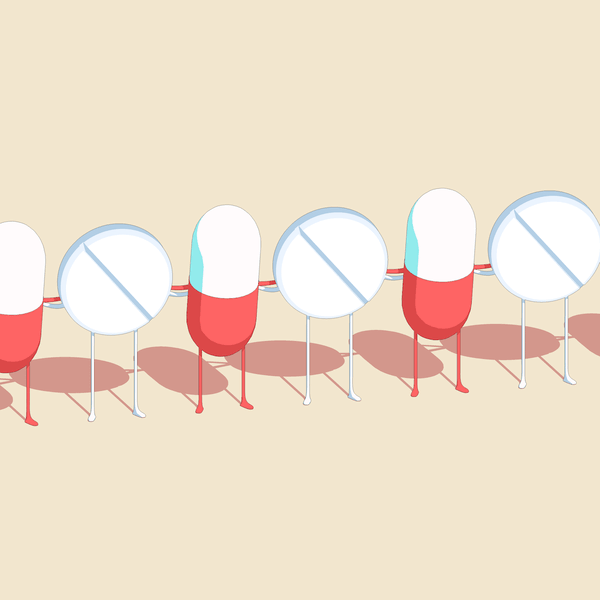Come te la racconti?
Quali racconti sull'alta sensibilità + Test per scoprire qual è il tuo.
Come (ci) raccontiamo l’alta sensibilità e perché è importante saperlo?
ALERT: Oggi troverai molte immagini colorate. Se ti danno fastidio, Mercoledì ti suggerisce di aprire la newsletter su Substack e di visualizzarne solo il contenuto scritto.
Nessuna storia è neutra. Raccontare è impiegare artifici. Ogni storia sull’alta sensibilità non solo informa, ma rende pensabili le cose + ci dice chi ha il diritto di raccontarle. O chi se lo prende anche se non l’avrebbe di certo, questo diritto, pensa Mercoledì, non senza polemica.
Ogni storia si appoggia su valori. E’ un bene l’alta sensibilità? O è solo un gran casino? Ci hai mai pensato? Alcuni, per esempio, sono convinti che l’alta sensibilità sia un dono che facciamo al mondo. Aspetta che svengo.
Raccontare è inevitabile. Ci raccontiamo continuamente, e non facciamo che fruire di racconti, dovunque e con chiunque.
E’ comprendere il mondo. Le storie servono a capire causa e effetto, aiutano a prevedere quello che viene dopo, danno un senso tollerabile a esperienze anche molto diverse. Della serie: che me ne faccio dell’alta sensibilità? A cosa mi serve esserne consapevole? Beh, a fare meno casini, pensa Mercoledì.
Costruire comunità. Che è una cosa bella, di solito. Non è un caso, allora, che sui social ci siano community che si ritrovano attorno ad una narrazione specifica di alta sensibilità. La maggior parte delle quali non mi rispecchia.
Raccontare ci spinge ad agire. Se credo alla narrazione secondo cui Trump è stato derubato delle elezioni, è del tutto logico pensare di entrare in Campidoglio con un paio di corna in testa. Tanto per fare un esempio eh.
Cambiare narrazioni significa cambiare. Scrive lo psicoanalista Zoja che “il racconto della vita è più importante della vita stessa”. Ovvero, tra le altre cose: 1) che raccontarsi impatta su come vivi; 2) per cambiare vita devi costruire storie nuove su di te.
E allora?
Quali racconti sull’alta sensibilità?
*ALERT: Non si tratta di una ricerca scientifica, ma di alcune “narrazioni” sull’alta sensibilità che Mercoledì ha analizzato criticamente leggendosi letteratura divulgativa e commerciale.
Iniziamo.
Gli specials
Soprannominati da Mercoledì: “quelli che se la cantano”. Siamo un dono che facciamo al mondo. L’intelligenza rara, l’intuizione e l’empatia: il mondo non ci ringrazia abbastanza. Sono quelli che vanno a scovare le biografie di persone famose per far emergere i segni della loro alta sensibilità (una volta andava di moda farlo con i dislessici. Toh, guarda, Einstein!). Questo tipo di narrazione - un po’ mitomane, francamente - spinge ad azioni che sostengono l’autostima per trovare la propria collocazione nel mondo, meglio se con qualcuno che ti adori. Di solito chi costruisce queste storie è una sedicente fonte autorevole che tende a costruire un mito, ricorrendo a qualcosa di tradizionale “che buca” e sa imporsi, rendendo immediatamente identificabile un contesto preciso.
I sopravvissuti
Sono i racconti che costruiscono la sensibilità come qualcosa che ha concorso nel farci soffrire, ha contribuito a traumi e malattie. Situazioni da cui siamo (faticosamente) sopravvissutǝ. E’, insieme, uno stanco canto del cigno e un’accusa ad una società percepita come cattiva e mediocre. Sono racconti che solleticano l’autocompiacimento di chi si esclude, facendo leva sull’inevitabile zaino personale di delusioni, traumi e ferite. Le communities di sopravvissutǝ si ritrovano attorno al farsi forza a vicenda (che non è una cosa brutta) e lo storytelling è tipicamente consolatorio e, in alcuni casi, recriminante. Scrive Bartezzaghi (2023, p. 35): “A chi è o si sente svantaggiato fa preferire risarcimenti illusori a veri e propri cambiamenti di statuto: offre pesci simbolici anziché canne da pesca funzionanti“. Attenzione.
I medicalizzati
Sono quelle narrazioni - tipiche dell’approccio medico trauma-riparativo, o meglio detto: se sei rotto ti ripariamo noi - che raccontano la sensibilità alla ricerca della co-morbidità. Sei anche ADHD, vero? No, meglio: Asperger. Intendiamoci, magari ci sono davvero altre cose da guardare: ma, in questo caso, a fare la differenza è la ricerca inesauribile di un’etichetta, meglio se medica, dietro la quale ripararsi. Le comunità che si appoggiano a queste storie sono sistematicamente asimmetriche. Da una parte ci sono quelli che si arrampicano sempre sulle loro expertise, hanno l’ultima parola, e, quando meno te l’aspetti, ti tirano fuori quel termine in latino, in cirillico, in aramaico che tu proprio non puoi sapere. Dall’altra parte, gli alunni disciplinati. Aiuto!
Gli showing-off
Detti anche i “guarda quante cose so fare” nonostante, grazie, o per via della mia sensibilità. Di solito maschi highly sensation seekers che parlano ai loro simili. Lo fanno condividendo quello che riescono a FARE FARE FARE, complici grandi capacità sportive e mentali. Va loro riconosciuto, eh. Sul piano emotivo lasciamo perdere, ma piuttosto di essere scoperti si danno alla macchia. La sensibilità è raccontata a voce alta. Come fossero eroi.
Certo, un eroe sensibile. Il cammino di scoperta dell’alta sensibilità è piuttosto codificato: c’è la fase della scoperta, il contatto col guru che ti dà chiavi di accesso che poi userai nelle prove da superare. L’eroe non può che costruire una narrazione anti-tragica che, ovviamente, DEVE finire bene. Le loro comunità sono composte, ovviamente, da eroi e da qualche loro adepto che deve comunque essergli funzionale a fare (o dimostrare) qualcosa. Che noiah.
I delicati
Le narrazioni dei delicati sono romantiche e romanzate. Qui la sensibilità è associata a specifiche scrittrici ed artiste. In primis, la povera Jane Austen - che sensibile non era, e che spesso ha umiliato la sensibilità dei suoi personaggi.
A proposito: vuoi sapere a quale personaggio della Austen assomigli di più? Clicca qui.
Le narrazioni dei delicati si concentrano sulle piccole gioie della vita quotidiana, nella natura, gatti e cani inclusi (ma si sa: online vanno forte). Sono voci sussurrate, in leggera e rassicurante penombra. Non c’è volontà, affermazione, ambizione espressa: c’è l’attesa di essere scoperti perché alternativi. In queste storie, la sensibilità è sensorialità, una certa idea di mondo profumato radicata nell’intimità delle relazioni contrapposta al mondo esterno che ha in mano il potere. Si tratta, di solito, di donne che parlano ad altre donne per rinforzarsi nelle proprie scelte di vita alternativa. Queste narrazioni assomigliano a quelle dei survivors per via del loro potenziale consolatorio, anche se in questo caso la portata è meno recriminante nei confronti della società “dei normali”.
I nerd
Mercoledì appartiene a questa narrazione, ca va sans dire. Sensibilità é analisi. Le narrazioni di questo tipo sono tese a capire che cosa significhi essere altamente sensibili, con esiti talvolta rassicuranti, altre volte ambivalenti e traballanti. In un angolo della loro testa, i racconti-nerd sanno, infatti, che è difficile dare un senso univoco alla sensibilità. Che dovranno dubitare per sempre, che più di qualche notte insonne è assicurata. Ciononostante, (si) studiano compulsivamente, ogni tanto rasentando il ridicolo. Ma che importa, i nerd manco se ne accorgono. Rifuggono i racconti esoterici e sensoriali. Infastiditǝ dall’ignoranza o dalla mancanza di consapevolezza, queste storie - e le relative comunità - sono ad alto funzionamento e corrono il rischio di essere escludenti, anche nei confronti degli altri altamente sensibili “meno cognitivi”.
Ora a noi: Qual è la narrazione che senti più tua?
Grazie per aver letto fino a qui!! ;)
Ci vediamo fra una settimana per iniziare l’anno oltre i terribili buoni propositi.
Ah: bevi responsabilmente a Capodanno, che l’alcool a noi fa subito l’effetto depressivo.
M(ercoledì)arzia
C) risposta corretta (Fonte).
Dalla lettura di Mercoledì.
Così un altro Natale è passato e a me da molti anni succede di pensare ogni anno a Natale le stesse cose, e cioè: che avendo io avuto pochi giocattoli nell’infanzia ed essendo cresciuta in una famiglia dove si dava poca importanza alle feste e alle tradizioni, ho custodito in me a lungo l’idea di un Natale prezioso, celebrato e felice, idea puntualmente ogni anno, nell’infanzia, delusa e distrutta.
Natalia Ginzburg, Magico Natale, 1971