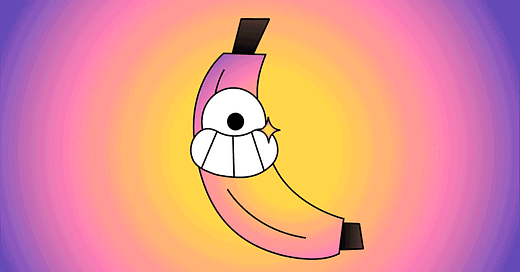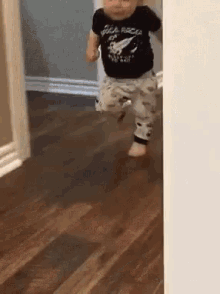Si chiama Folk Psychology: quell’insieme di teorie popolari e senso comune che usiamo per spiegare la vita ma che - attenzione - NON è scientificamente valido. In parte, l’acquisisci a casa. Altre teorie le hai lette qua e là e negli anni le fatte tue. Molte, invece, si sono amplificate online. Hanno qualcosa da dire su tutto: educazione (quanti danni ci ha fatto, ad esempio, l’umiliazione come strategia di motivazione!), giusto e sbagliato, amore e amicizia.
Traslate in ambito medico, è come se, ogni volta che dobbiamo farci una doccia, dicessimo: “Eh no, devi aspettare due ore dopo aver mangiato”. Ovviamente, ha un senso medico dirlo - puoi beccarti una congestione se stai facendo il bagno in un fiordo norvegese dopo aver mangiato la parmigiana di melanzane, se sei cardiopaticǝ -, ma potrebbe non essere adatto alla situazione specifica.
La folk psychology funziona allo stesso modo: nel tentativo di spiegare cose difficili, ha sempre qualcosa di sensato da dire - altrimenti non le userebbe nessuno. Se meglio analizzata, però, la sua fallacia si basa su tre elementi ricorrenti: eccessive semplificazioni, status eccezionali che diventano norma e, soprattutto, mancata validazione scientifica.
E’ talmente pervasiva da indirizzarti verso scelte di vita anche completamente sbagliate.
Un esempio?
Gli opposti si attraggono.
Grande bufala relazionale: due persone con opposti valori, funzionamenti psicologici lontani e differenti abitudini di vita non stanno bene insieme.
“Sì, ma, mia cugina sta con il suo opposto caratterialmente”.
Bene, ne siamo felici.
Questo, però, è esattamente come funziona il meccanismo di validazione implicita di una teoria “folk”: utilizza l’eccezione per stabilire la norma. Ci sarà pure quella relazione fra opposti che funziona, d’accordo, ma non è stata testata empiricamente e, se analizzata nel dettaglio, di solito rivela altro.
Mercoledì oggi ha come compito quello di smascherare alcune di queste teorie - sulle relazioni di coppia, sul funzionamento al lavoro e sulle fasi della vita. Se pensi, come me, che Mercoledì vada condivisa il più possibile, ecco il bottone per farlo.
Nel 1996, David Hammer, un professore di fisica della Tufts University, si mette a studiare come ragionano i suoi studenti, fisici come lui. Cosa ne viene fuori? Che pure loro usano numerose teorie di folk psychology sulla scienza: false credenze, profondamente radicate, che influenzano il modo con cui si comprende la realtà. Hanno il brutto difetto di perdurare nonostante siano contraddette da prove consolidate (qui il link allo studio). Ti ricorda qualcosa di recente? A me sì.
Come se ne esce?
Solo rettificandole per benino.
Roger, cominciamo.
1. La sindrome dell’impostore non esiste
Facciamocene una ragione (Fonte). Ce lo dice anche la Soncini, come solo lei sa fare.
Nel secolo in cui la mitomania va venduta come vittimismo, e ogni convintamente genio convintamente incompreso prima o poi abbassa gli occhi e ti dice sai, soffro della sindrome dell’impostore. Che significherebbe che non sai di valere, ma se non sai di valere non sai neanche che vali più di quel che sai, e quindi non è quella sindrome che se dici di avercela non ce la puoi avere?
Guia Soncini, L’economia del sé, 2022, pp. 188-189Non è che te la sei inventata, intendiamoci. E’ dovunque, chiunque di noi per cinque minuti si è convintǝ che quella fosse la risposta a tanti interrogativi. E però è sbajata.
Come si spiega tanta popolarità, allora?
Intanto, perché è da un po’ che se ne parla.
La sua “scoperta” è del ‘78. Due psicologhe osservano che donne di successo hanno frequenti pensieri negativi: pur ottenendo importanti risultati, li attribuiscono al caso (non al loro duro lavoro) e pensano di non valere molto, in fondo. Da lì in poi il concetto viene adottato da una marea di magazine e da libri di auto-aiuto (ne abbiamo parlato qui).
Poi, però…
Un pool di studi ha deciso di vederci meglio e ha dimostrato che l’emersione della sindrome dipende largamente dagli strumenti utilizzati. In più, queste ricerche avevano una valanga di bias (errori nella selezione del campione, problemi di riproducibilità, cose così).
Eppure, intendiamoci, quella cosa per cui chi ha successo può dubitare continuamente di sé può capitare, soprattutto se non si è maschi WASP. Però, non è una patologia, non ci sono indicazioni di trattamento né terapie verificate. Tradotto: siccome a livello clinico e terapeutico non esiste, se qualcuno te la diagnostica: gambe in spalla, ragazzǝ!!
Non è tutto da buttare, però.
Alcuni costrutti psicologici effettivamente testati possiamo ritrovarli in questa situazione. Eccone alcuni.
Stigma interiorizzato: è quell’insieme di vissuti negativi e pregiudizi che le persone hanno quando vivono uno stigma di qualsiasi natura legato alla loro condizione mentale, sociale, fisica, di genere, sessuale. Di solito è associato ad un profondo senso di vergogna.
Perfezionismo: è un tratto di personalità, genericamente inteso come la tendenza a rifiutare qualsiasi imperfezione.
Bassa autostima: è una condizione psicologica che implica una scarsa fiducia in se stessi, paura di sbagliare o deludere gli altri.
Minority stress: è la condizione di conflitto e di costante stress sperimentata da chi appartiene ad una minoranza (anche essere donne in certi ambiti può esserlo: non in termini numerici, ovviamente, ma in termini di potere), per via di diversi valori in gioco oppure di condizioni di vita progettate per altri (la sto studiando sugli studenti universitari altamente sensibili, ti saprò dire).
Tutte condizioni non cliniche.
Allo stesso tempo, però, pare che in chi si ritrova in questa sedicente sindrome abbia anche qualche forma di ansia e depressione, burnout e insoddisfazione lavorativa (ne abbiamo parlato in questa vecchia edizione di Mercoledì).
Saresti l'ultimǝ a saperlo, se fossi in burnout
Gennaio è un mese impietoso. Dall’alto dei suoi interminabili 31 giorni, ti fa capitare un po’ di tutto. Come questa telefonata.
Se pensi che ti possa servire un aiuto psicologico, ricordati di consultare chi di competenza.
ATTENZIONE: Non è “questione di lana caprina” parlare bene psicologese. Se uso la psicologia correttamente, mi faccio ingannare di meno da chi mi vuole manipolare e ho una corretta “igiene della mente”. Chiamare le cose con il proprio nome - quello corretto - fa la differenza.
2. Adolescenza e mezza età = crisi. Falso!
Partiamo dalla prima.
E’ del tutto probabile che insegnanti, genitori, infermieri, anche psicologi - tutti, praticamente - siano convinti che adolescenza significhi crisi. E lo dicono basandosi generalmente su questi tre principi: 1) in adolescenza aumenta la conflittualità con i genitori, 2) gli adolescenti sono più instabili emotivamente, e 3) attuano più comportamenti rischiosi. Ognuno di questi tre punti ha una letteratura scientifica alle spalle. E però.
Come si spiega, allora, che in società tradizionali diverse da quella occidentale - Cina, India, Giappone, mondo arabo e Africa sub-sahariana - l’adolescenza sia una fase di relativa calma e tranquillità, senza drammi con i genitori?
E ancora: com’è che in relazione alla crescente occidentalizzazione di alcuni di questi paesi, aumenti anche il disagio degli adolescenti (Fonte)? Della serie: “lo portiamo noi”? Beh, forse sì.
Non sminuiamo l’adolescenza e le sue manifestazioni cliniche: come insegnano gli/le psicoterapeutǝ, in effetti molte importanti patologie mentali insorgono - ovvero, si vedono di più - proprio in questa fase. Non sono tutti gli adolescenti in crisi, ma alcuni sì, di sicuro. E allora bisogna ascoltarli.
Liquidare i problemi degli adolescenti come una "fase passeggera" o come la manifestazione di un normale periodo di crisi potrebbe precludere a teenager in grave difficoltà la possibilità di ricevere l'assistenza psicologica di cui hanno grande bisogno (Offer et al., 1992). Se, da un lato, bisogna ammettere che in alcuni casi le grida di aiuto degli adolescenti sono stratagemmi manipolatori per ricevere attenzione, dall'altro è necessario riconoscere come in molti casi si tratti di segnali inviati da giovani disperati, la cui sofferenza è stata ignorata.
Scott O. Lilienfeld et al., 2010, I grandi miti della psicologia popolare, p. 63Veniamo ora alla mezza età, quell’ondivaga percezione di sé che arriva dopo aver compiuto i 40 anni. Alzi la mano chi non ha mai pensato: “è ovvio che è in crisi di mezza età” (sì Ben, l’abbiamo pensato anche di te).
Anche in questo caso, qualche verità psicologica c’è.
Intanto, perché la “crisi di mezz’età” l’ha inventata uno psicoanalista, Elliott Jacques, nel 1965. Poi perché, qualche anno più tardi, un altro grande psicologo, Erik Erikson, ha visto che in effetti fra i 40 e i 60 la gente si domanda che senso ha la vita, operando “correzioni” di varia natura.
Studi più recenti (Fonte) hanno però dimostrato che la crisi di mezz’età non esiste. In particolare:
le persone dopo i 40 si sentono più in controllo a livello psicologico, sperimentando maturità e benessere inediti fino ad allora;
andare in crisi non è una prerogativa solo dei 40enni: a tutte le età capita di riconsiderare obiettivi e priorità;
i divorzi, poi, ci sono prima, di solito. E’ stato calcolato, ad esempio, che in America ci si lasci in media dopo 5 anni di matrimonio (altro mito sfatato: quello della crisi dei 7 anni);
chi si compra una Porsche a 50 anni, tradizionale esempio forse un po’ datato, non è perché è in “crisi”, ma più probabilmente perché, dopo averlo sempre desiderato, ha finalmente la disponibilità per farlo;
ah, non esiste nemmeno “la sindrome da nido vuoto": quella che sperimenterebbero le nostre madri quando ce ne andiamo di casa (Fonte)! Mamme me lo confermate?
Sulla bufala psicologica della crisi di mezz’età quanta filmografia ci ha marciato? In alcuni casi, lasciandoci anche bei film.
3. E’ tutto dannatamente “tossico”
Anche in questo caso, non è lessico psicologico: è Britney Spears. Correva l’anno 2003.
Niente, nemmeno una relazione, può definirsi tossica, come se fosse una sostanza. Semmai, ci sono relazioni in cui le cose non funzionano “bene” - finanche relazioni manipolatorie - e persone che ci fanno violenza psicologica, questo sì. Qui un approfondimento su questo funzionamento in coppia e qui sulla manipolazione al lavoro.
Grazie per aver letto fino a qui! ;)
Per commenti, basta rispondere a questa mail – e sì, rispondo a tutte le mail.
M(ercoledì)arzia
Dalla lettura del Mercoledì.
Ci sono cose che, a un certo punto, capiamo. Sappiamo che sono così, ma lo sappiamo solo noi ed è veramente difficile trasmetterle agli altri, e lo sappiamo con tanta intima sicurezza che quasi ci passa la voglia di dimostrarlo. E’ la parte oscura della conoscenza, un’intuizione incondivisibile, profonda, che dà più amarezza che soddisfazione.
Antonio Franchini - Leggere, possedere, vendere, bruciare - p. 117